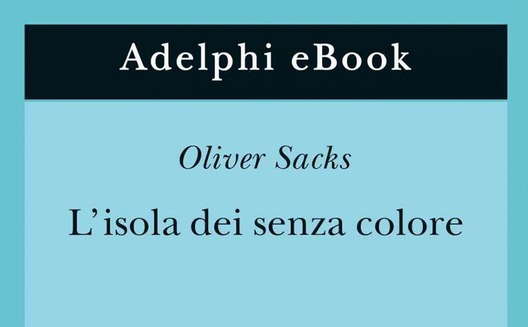Pingelap è un atollo della Micronesia. Un anello spezzato intorno ad una laguna centrale, del diametro di un paio di chilometri. È coperto da una vegetazione primordiale e lussureggiante, che stordisce per le miriadi di sfumature di verde, di luci e di ombre che sollecitano lo sguardo. La foresta pluviale, la barriera corallina, la particolare conformazione dell’atollo rendono il luogo un paradiso di colori e, proprio in questo paradiso, vive la più grande comunità di acromatopsici: un’alta percentuale della popolazione di quest’isola è completamente cieca ai colori.
Pingelap è un atollo della Micronesia. Un anello spezzato intorno ad una laguna centrale, del diametro di un paio di chilometri. È coperto da una vegetazione primordiale e lussureggiante, che stordisce per le miriadi di sfumature di verde, di luci e di ombre che sollecitano lo sguardo. La foresta pluviale, la barriera corallina, la particolare conformazione dell’atollo rendono il luogo un paradiso di colori e, proprio in questo paradiso, vive la più grande comunità di acromatopsici: un’alta percentuale della popolazione di quest’isola è completamente cieca ai colori.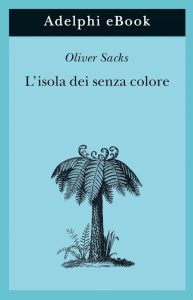 Pingelap è la meta del neurologo e neuroantropologo Oliver Sacks, che, ne L’isola dei senza colore (Adelphi 1997=2007, pp. 334), descrive il viaggio scientifico in Micronesia, compiuto per studiare la particolarità genetica di alcune tra queste isole.
Pingelap è la meta del neurologo e neuroantropologo Oliver Sacks, che, ne L’isola dei senza colore (Adelphi 1997=2007, pp. 334), descrive il viaggio scientifico in Micronesia, compiuto per studiare la particolarità genetica di alcune tra queste isole.L’opera, che intreccia i generi del trattato scientifico, il resoconto naturalistico ed il racconto di viaggio, racconta nella prima parte l’isola degli acromatopsici, e, nella seconda parte del libro, gli effetti devastanti del lytico-bodig, una paralisi progressiva che colpisce alcune famiglie dell’isola di Guam, e soltanto coloro nati in un definito arco di tempo.
Gli occhi degli acromatopsici congeniti, spiega Sacks, sono privi di coni funzionali: mancano quindi le cellule specializzate alla percezione dei dettagli fini e dei colori. Queste cellule, nei soggetti normali stanno nella fovea, ossia la parte centrale della retina. Chi ne è sprovvisto deve affidarsi, per la visione, all’afferenza visiva dei bastoncelli, che non possono distinguere il colore ma sono straordinariamente sensibili alla luce. In presenza di luce intensa i bastoncelli si saturano in breve tempo e cessano di funzionare: ne consegue che il campo visivo di un “senza colore”, alla luce del sole, si contrae all’istante riducendosi quasi a zero.
Per questo motivo, la prima immagine che Sacks si trova di fronte, una volta giunto nell’isola di Pingelap, è uno sciame di bambini festosi, tra i quali alcuni strizzano di occhi e cercano di ripararsi dal sole intenso: sono i bambini nati col maskun (così viene chiamata sull’isola la condizione dell’acromatopsia).
L’origine dell’anomalia genetica è rintracciabile in un fatto storico: sul piccolo atollo di Pingelap si abbattè nel 1775 un violento tifone. Il novanta per cento della popolazione morì subito, i sopravvissuti furono decimati dalla fame, dal momento che tutta la vegetazione che costituiva la base per l’alimentazione andò distrutta, lasciando come unico sostentamento il pesce; in qualche settimana la popolazione si ridusse ad una ventina di persone.
Grazie allo straordinario impegno riproduttivo dei sopravvissuti, in pochi decenni l’isola si ripopolò, ma le conseguenze del necessario incrocio fra consanguinei non tardarono a presentarsi: intorno agli anni venti dell’Ottocento nacquero i primi bambini con il maskun. All’epoca della ricerca di Sacks, la percentuale di acromatopsici era di uno su dodici, mentre altrove nel mondo è di circa uno su trentamila.
Sacks racconta, con lo sguardo curioso ed avido di conoscere di un moderno esploratore, i cibi, le bevande, i colori e i comportamenti della comunità, dove chi ha il maskun non viene isolato, anzi. Gli si riconosce la particolare abilità a distinguere le tonalità di luminanze o ad apprendere determinati saperi.
Come far a riconoscere i frutti maturi sugli alberi, senza avere la percezione del colore? Lo si racconta in un episodio, in cui viene chiesto alla guida della spedizione, anch’essa affetta da maskun:
“«E le banane?» chiese Bob «Riuscite a distinguere quelle gialle da quelle verdi? «Non sempre» rispose James. «Il verde pallido può sembrarmi uguale al giallo»
«E allora come fate a dire quando una banana è matura? ». Per tutta risposta, James si avvicinò a un banano e tornò portando a Bob un frutto scelto con attenzione, di un bel verde brillante.
Bob provò a sbucciarlo, e si accorse, sorpreso, che la buccia veniva via facilmente. Diede un piccolo morso d’assaggio, con circospezione; e subito divorò il resto. «Vedi,» spiegò James «noi semplicemente non ci basiamo sul colore. Guardiamo, tastiamo, odoriamo, sappiamo: prendiamo in considerazione tutto, mentre voi pensate solo al colore! »”.
La seconda parte del libro racconta il prosieguo del viaggio di Sacks a Guam, dove una sindrome postencefalica, endemica sull’isola, colpiva alcune famiglie decimandone i componenti, attraverso paralisi progressiva (lytico) o tremori simili al parkinsonismo (bodig). La ricerca delle cause della malattia hanno appassionato i ricercatori per decenni, senza tuttavia pervenire ad una spiegazione soddisfacente.
L’ultimo breve resoconto di Sacks è dedicato all’isola di Rota, coperta da foreste di felci e cicadine, che può dare un’idea della vegetazione sulla Terra durante il Giurassico (150 milioni di anni fa): in una nota Sacks spiega che le foreste, pochi anni dopo la sua spedizione, erano state quasi totalmente distrutte per far spazio a campi da golf.
L’Isola dei senza colore è un volume che non può mancare nella biblioteca dei curiosi e dei viaggiatori: insegna lo sguardo ricettivo e rispettoso che si dovrebbe usare quando si osserva qualcosa che ci è estraneo e sconosciuto, usa un linguaggio scientifico ma comprensibile anche da chi non è “addetto ai lavori”, incuriosisce e suggerisce il viaggio di scoperta interiore che sempre accompagna chi viaggia per conoscere. Buona lettura!
Eleana Marullo
Copyright (C) 2010 – Eleana Marullo – Riproduzione riservata.